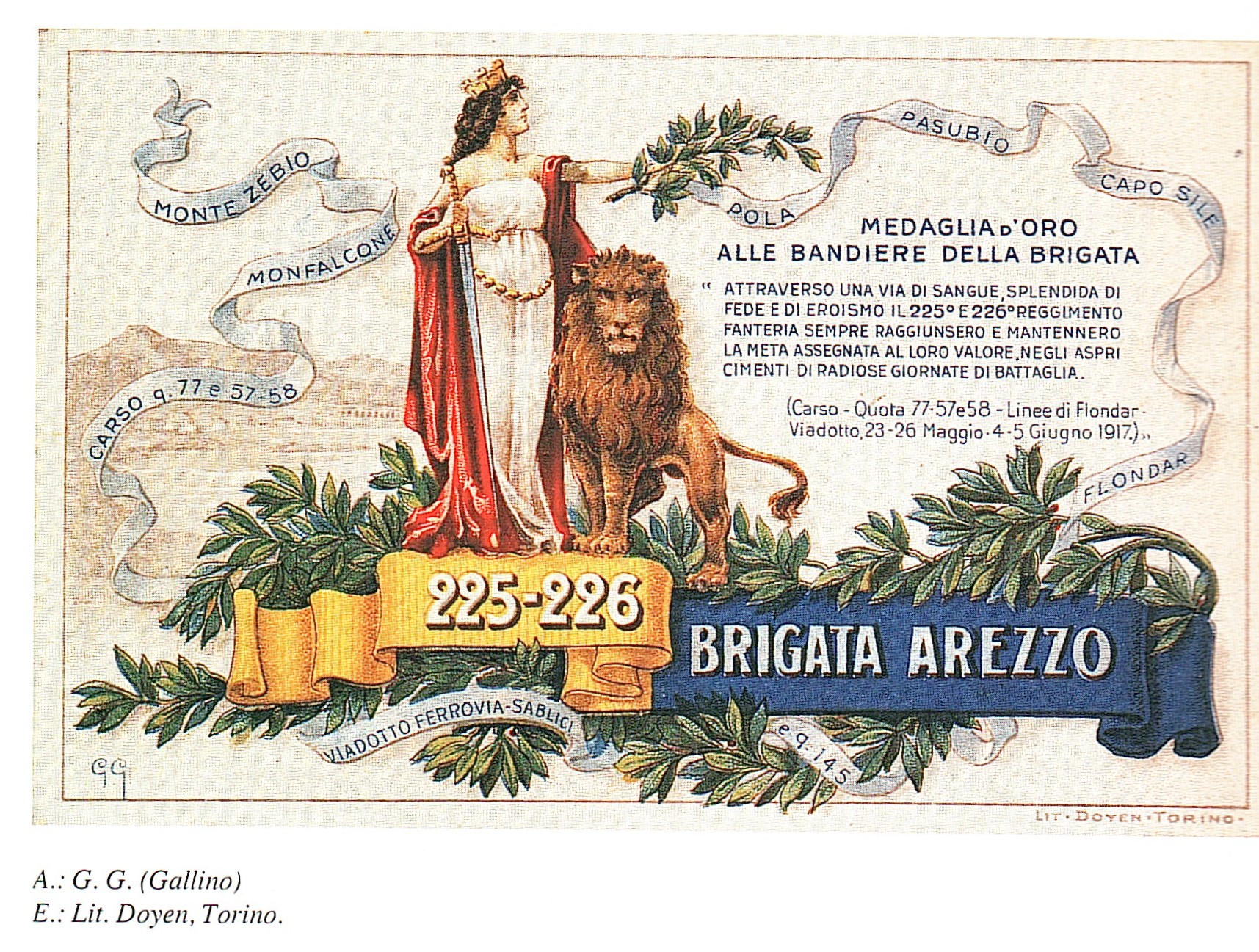
PROGETTO SCUOLA IN LABORATORIO ANNO 2021
Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi”
Referente: Prof.ssa Alessia Biasiolo – Partecipanti: Classi Seconde e Terze
L’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi”, è un Ente di Formazione Professionale del Comune di Lumezzane (Brescia), certificato ISO 9001 e accreditato presso la Regione Lombardia per i settori della Formazione e del Lavoro.
Svolge la propria missione da sessant’anni, rispondendo con puntualità e professionalità alle richieste che giungono dal territorio della Valle Trompia, della Valle Sabbia e della Valle Gobbia.
Il Centro di Formazione Professionale è uno degli attori principali della promozione educativa, formativa, dell’orientamento e dello sviluppo locale nel territorio. I corsi offerti per gli studenti DDIF sono quattro, articolati in:
Corso per Operatore e Tecnico del Benessere
Studentesse che si preparano per diventare estetiste.
Corso per Operatore e Tecnico Elettrico
Studenti che si preparato per diventare elettricisti.
Corso per Operatore e Tecnico di Sala e Bar
Studenti e studentesse che si preparano per diventare camerieri di sala o di bar.
Corso per Operatore e Tecnico di Panificazione e Pasticceria
Studenti e studentesse che si preparano per diventate panificatori e/o pasticceri.
Elaborati della Classi II
Il Milite Ignoto attraverso le fotografie di Javaria I.
Nella prima fotografia analizzata si vedono le 11 bare dei soldati ignoti. Le bare si trovano all’interno della chiesa di Aquileia. Poi c’è un’immagine della bara del Milite Ignoto. Sopra sono appoggiati la bandiera dell’Italia, un elmetto e un fucile.
Nell’immagine seguente si vede il treno che ha portato la bara del Milite Ignoto a Roma. Il treno è decorato con fiori e ghirlande. Lungo i binari si vedono tante persone inginocchiate. E tante con bandiere.
Nelle fotografie si vedono alcune persone salite sui tetti per vedere meglio, altri che alzavano bambini per fargli vedere il treno. Si vede il treno all’arrivo a Roma. La bara viene presa da alcuni soldati e caricata su una carrozza.
Il Milite Ignoto di Davide G.
Il Milite ignoto, o soldato ignoto, era un militare italiano trovato al fronte durante la prima guerra mondiale, morto e sepolto a Roma sotto la statua della dea Roma, all’entrata del Vittoriano. Nessuno sapeva chi fosse, un motivo per chiamarlo ignoto è questo. Lui fu sepolto fra tutti quei caduti in guerra privi di indizi che potessero permetterne il riconoscimento. Questa tomba è un simbolo per tutti coloro che sono morti e dispersi nella guerra in Italia. Il 4 novembre si festeggia la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. Luigi Gasparotto, ex senatore della Repubblica italiana, chiese a Francesco Nitti di poter festeggiare o comunque ricordare questo giorno. Questa scelta a pare mio fu importante per tutti gli italiani. Un ricordo che probabilmente resterà nei cuori di tutte le generazioni nuove e vecchie.
Basilica di Santa Maria Assunta di Aquileia, di Andrea A.
È il principale edificio religioso di Aquileia, un’antica cattedrale. I resti più antichi sono del IV secolo ed è stata rinnovata nel XIII secolo; è a lato della Via Sacra, affacciata su Piazza del Capitolo, insieme al Battistero e al campanile. Fu costruita nell’anno dell’Editto di Costantino. Gli edifici di questa costruzione appoggiavano su edifici romani di cui sono state usate le mura perimetrali. Si entrava da Est e si accedeva ai vari locali. Nel IV secolo fu ampliata l’aula Nord ed è stato costruito un portico davanti alla facciata. Al vescovo Cromazio si deve l’ingrandimento dell’aula Sud e la costruzione del Battistero. Dietro alla Basilica c’è il cimitero dei caduti della Grande Guerra, dove sono sepolti i dieci militi ignoti rimasti ad Aquileia e tra di loro Maria Bergamas, mamma di un volontario di guerra morto sugli altipiani vicentini. Maria scelse il milite che ora riposa sotto l’Altare della Patria, a Roma, dal 1921.
Il Vittoriano, di Loris M.
Il Vittoriano è un monumento nazionale italiano, si trova a Roma, in Piazza Venezia, ed è stato costruito dall’architetto Giuseppe Sacconi; la sua costruzione durò cinquant’anni, dal 1885 al 1935, ma già nel 1911 fu inaugurato e aperto al pubblico.
Il progetto del Vittoriano è ispirato ai santuari ellenistici; sulla sua sommità ci sarebbe stato un portico con un lungo colonnato e due propilei, uno dedicato alla “Libertà dei cittadini”, mentre l’altro dedicato alla “Unità della Patria”, entrambi concetti legati a Vittorio Emanuele II che lì venne sepolto.
Per costruire il Vittoriano si dovevano usare il marmo e il Travertino, ma alla fine venne usato solo il marmo, che sarebbe dovuto essere marmo di Carrara, ma per la Commissione reale il marmo di Carrara aveva un prezzo troppo elevato, quindi fu usato il marmo di Botticino.
Il Vittoriano è stato costruito sul Campidoglio e non fu una scelta casuale, perché, secondo la leggenda, è sul Campidoglio che fu fondata Roma; simbolicamente fu deciso di costruire il Vittoriano in perfetta contrapposizione alla basilica di San Pietro, simbolo del potere temporale dei papi.
Per costruire il Vittoriano fu indispensabile demolire interi quartieri, molte persone erano contrarie alle demolizioni tra cui il sindaco di Roma, Leopoldo Torlonia, l’archeologo Rodolfo Lanciani e Ruggero Bonghi, che manifestò la sua disapprovazione in Parlamento.
Ci furono anche delle persone favorevoli alle demolizioni, come lo storico dell’Arte Giovanni Battista Cavalcaselle e l’architetto Camillo Boito.
Il Sacrario militare di Redipuglia, di Nicolò P.
Il Sacrario è situato in Friuli-Venezia Giulia ed è un cimitero militare. È stato costruito in epoca fascista, inaugurato il 18 settembre 1938, e conta centomila militari morti durante la prima guerra mondiale. La struttura comprende più di cento ettari e così lo rendono uno dei più grandi sacrari del mondo. È amministrato dal Ministero della Difesa e serve anche come luogo per commemorare tutti i 689mila soldati italiani morti nella Grande Guerra.
Il Sacrario fu progettato da un gruppo di lavoro presieduto dallo scultore Giannino Castiglioni e dall’architetto Giovanni Greppi. I lavori iniziarono nel 1935 e finirono tre anni dopo, con la presenza di Mussolini e di 50mila veterani della guerra all’inaugurazione. Nel 2018 il Sacrario ha avuto bisogno di restauro.
È realizzato sul Monte dei Sei Busi, si presenta come uno schieramento di gallerie, crateri, munizioni inesplose, trincee e nidi di mitragliatrici. Ci sono 22 scalinate in cui sono allineate le tombe dei caduti. Il duca d’Aosta, morto nel 1931, aveva chiesto di essere sepolto lì e in quel santuario si trova anche la tomba di Margherita Kaiser Parodi che è l’unica donna ad essere sepolta in quel luogo. Venne costruito di fronte al primo cimitero di guerra della Terza Armata che ora è un museo.
La cappella della chiesa è rettangolare e con tre croci sopra; in essa e nelle due sale adiacenti vi sono custoditi oggetti personali dei soldati ed è arricchita con una statua dell’Assunta che vuole indicare la necessità di fare il sacrario di raccordo al fine di una riflessione etica su chi fa una guerra; nella cappella si trova anche la testa di un Cristo sofferente trovata nel 1995 nella dolina dov’erano i militari. Alla sua base si trova la tomba di Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta che era comandante della Terza Armata.
Ricinge simbolicamente l’ingresso del Sacrario una grossa catena che appartenne alla torpediniera della Marina austro-ungarica, ceduta all’Italia alla fine della guerra; subito dopo si trova un piazzale, davanti c’è la Via Eroica che corre tra due file di lastre di bronzo, 19 per lato. Sulla porta c’è incisa una località dove lo scontro è stato più sanguinoso, in fondo a questa Via si trova la gradinata che custodisce i corpi di 40mila soldati. La scalinata di pietra che forma il Sacrario è davanti alla collina di Sant’Elia, dove si trovava il precedente cimitero di guerra. I resti dei militari sepolti lì sono stati traslati in questo Sacrario. L’intera zona è stata convertita in Parco del Ricordo o della Rimembranza. Sul sito bellico è conservata una croce del Monte Sei Busi, che onorava una grande fossa comune. Nel 2014 la cappella venne trasformata in chiesa.
Il Vittoriano, di Christian S.
Il monumento nazionale a Vittorio Emanuele II si trova a Roma. La sua costruzione iniziò nel 1885 e i lavori si conclusero nel 1935, ma già dal 1911 il monumento era aperto al pubblico, per il cinquantesimo dell’Unità d’Italia. Dal punto di vista architettonico è stato pensato come un moderno foro, un’agorà su tre livelli collegati da scalinate e caratterizzato da un colonnato. Fu progettato da Giuseppe Sacconi che seguì i lavori per vent’anni, fino alla morte avvenuta il 23 luglio 1905. Insieme a tutto il monumento fu inaugurata una statua, il Monumento equestre a Vittorio Emanuele II. La statua bronzea fu posta su un basamento marmoreo dove furono scolpite le personificazioni di 14 città italiane. Fu costruita da Emilio Gallari ed Enrico Chiaradia dal 1889 al 1910.
Antonio Bergamas, di Monica C.
Antonio Bergamas fu un militare volontario durante la Grande Guerra. È nato a Gradisca d’Isonzo; da bambino si trasferisce con la famiglia a Trieste e poi a Capodistria dove ha frequentato le scuole magistrali. Negli ideali repubblicani fu ammiratore di Mazzini, del primo Futurismo e dell’Irredentismo. Il 3 ottobre 1914 entrò in Fanteria a Carmons trasferendosi a Roma e poi a Venezia.
Nel maggio 1915 in alcune manifestazioni interventiste, Bergamas scelse di arruolarsi come fante nella Brigata “Re”.
Nell’estate del 1915 partecipò ad un concorso a Carmons per essere ammesso alla Scuola Militare di Modena, ma venne respinto per aver scritto un tema ritenuto dagli esaminatori troppo ironico e sovversivo. La penuria di ufficiali nell’Esercito Italiano, nei mesi successivi, gli permisero di partecipare al concorso per sottotenente nella Brigata “Barletta”, dove combatté sul Monte Sei Busi e nella zona di Castelnuovo.
Nel maggio 1916 l’Austria-Ungheria scatenò la Strafexpedition e il suo reparto venne inviato sul Monte Cimone, sull’Altipiano di Asiago.
Il 18 giugno 1916, alle ore 8 del mattino, assieme al suo plotone di zappatori, Antonio Bergamas fu mandato sulle posizioni austroungariche, ma una mattina una raffica di mitragliatrice lo colpì a morte; venne sepolto in zona e il corpo non venne mai trovato.
Si ritiene che sia stato posto nella fossa comune del Cimitero Militare Monumentale “Medaglia d’Oro Pietro Marocco” di Arsiero. Il suo corpo si trova idealmente all’Altare della Patria. Nel 1921 sua madre, infatti, fu eletta rappresentante di tutte le madri dei soldati dispersi nella Grande Guerra per scegliere la bara del Milite Ignoto che fu deposto nel Vittoriano di Roma. Antonio scrisse una lettera con parole molto toccanti per la madre.
Maria Bergamas, di Francesca C.
Maria Bergamas, il cui nome completo è Maria Maddalena Blasizza in Bergamas, è stata la donna italiana che fu scelta in rappresentanza di tutte le madri italiana che avevano perso un figlio durante la prima guerra mondiale. Era figlia di Giacomo Blasizza che faceva il fabbro, e sua madre Orsola Maur era lavandaia; entrambi erano originari di Farra d’Isonzo, in Friuli Venezia-Giulia. Maria Bergamas visse a Trieste, dove si era trasferita quando era molto giovane, e dove risiedeva alla scoppio della Grande Guerra.
Il 28 ottobre 1921 fu proprio lei, Maria Bergamas, a decidere tra gli undici corpi senza nome di soldati morti in trincea, riuniti nella Basilica di Aquileia, chi sarebbe stato portato a Roma, per esser accompagnato e sepolto all’Altare della Patria come Milite Ignoto. Quella cerimonia passò alla storia con il nome di “Rito di Aquileia”.
Maria fu posta davanti alle undici bare e dopo essere passata davanti alle prime, non riuscì a continuare, così si mise a gridare il nome del figlio, cadde al suolo davanti a una bara che venne scelta. La bara scelta fu messa sull’affusto di un cannone e, accompagnata da decorati al Valore Militare e più volte feriti, venne messa su un carro ferroviario appositamente disegnato. Maria Bergamas, insieme al tenente, salì a bordo del treno che portava il corpo del Milite Ignoto a Roma, facendo tappa nelle varie città d’Italia per ricevere l’abbraccio di tutti gli italiani.
Maria Bergamas morì nel 1952. Nel novembre 1954 fu sepolta nel cimitero di guerra retrostante la Basilica di Aquileia, vicino ai dieci corpi dei Militi Ignoti rimasti là.
Antonio Bergamas, figlio di Maria, era nato a Gradisca d’Isonzo nel 1891 e morì a Tonezza del Cimone nel 1916. Fu un militare volontario irredento durante la Grande Guerra.
Il mio pensiero su questa scelta è molto semplice: ero molto incuriosita dalla storia di Maria, sul perché avesse scelto proprio quella bara. E devo dire che per me è stata molto coraggiosa, è molto affascinante la sua storia.
Milite Ignoto, di Laiba A.
Il Milite Ignoto era un soldato caduto al fronte durante la prima guerra mondiale, sepolto anonimamente, la cui identità resta ignota.
La tomba del Milite Ignoto rappresenta simbolicamente tutti i caduti e i dispersi in guerra; è scenario di cerimonie ufficiali che si svolgono annualmente in occasione di festività civili, durante le quali il Presidente della Repubblica Italiana e le massime cariche dello Stato rendono omaggio al Sacello del Milite Ignoto con la deposizione di una corona d’alloro.
Milite Ignoto. Il Vittoriano, di Michelle V.
Dopo la morte di Vittorio Emanuele II di Savoia, avvenuta il 9 gennaio 1878, furono molte le iniziative destinate a innalzare un monumento che celebrasse il primo Re dell’Italia Unita.
Nel 1885 iniziò la costruzione di un monumento grandioso a Roma; il progetto era di Giovanni Sacconi, giovane architetto delle Marche.
Visto che si tratta di un monumento molto importante, è protetto dalla Marina Militare: si tratta di undici militari comandati da un sottufficiale che turnano la guardia.
Il Vittoriano per l’Italia è considerato il luogo di riferimento per le grandi mostre d’arte della capitale, quello in assoluto più visitato.
La sconfitta di Caporetto, episodio della prima guerra mondiale, di Sara M.
La disfatta di Caporetto iniziò poco più di cent’anni fa con un attacco a sorpresa, in cui erano complici gli austriaci e i tedeschi.
Il 24 ottobre del 1917 tonnellate di gas tossici e proiettili iniziarono a cadere vicino al piccolo paese di Caporetto. Nelle ore successive i soldati austriaci e tedeschi attaccarono. Dopo una giornata di combattimenti, i generali italiani ordinarono alle truppe di ripiegare. La ritirata l’avrebbero fermata soltanto quattro settimane dopo, sulla famosa linea del Piave; quarantamila soldati italiani furono uccisi o feriti e altri 365mila vennero imprigionati. Questa sconfitta si svolse durante la prima guerra mondiale. L’Italia era entrata nel conflitto due anni prima, con l’obiettivo di tornare in possesso delle terre irredente rappresentate da Trento e Trieste. I principali luoghi di scontri furono le valli e le montagne dell’Altopiano di Asiago, nel Veneto settentrionale, e dell’Altopiano del Carso che è al confine tra l’odierna Slovenia ed il Friuli Venezia-Giulia, lungo il fiume Isonzo.
Ci furono dodici battaglie, tutte combattute nella stessa zona e con una dinamica e un obiettivo simili: sfondare la linea nemica e far ritirare gli austriaci. I generali italiani provarono grandi attacchi, piccoli attacchi preceduti da lunghi bombardamenti, attacchi a sorpresa, attacchi di giorno e anche di notte. Le perdite furono sempre altissime e il fronte austriaco non venne mai sfondato.
L’esercito della battaglia di Caporetto si era dimostrato inadeguato al conflitto moderno, c’era aria di rivoluzione e l’antica monarchia sembrava più incerta, solo il fronte italiano sembrava reggere. La Germania non poteva permettersi di perdere il suo alleato, così volle togliere di mezzo l’Italia con un colpo a sorpresa. La mattina del 24 ottobre vennero lanciati i gas tossici, gli italiani però avevano le maschere antigas; poco dopo arrivò l’artiglieria che spazzò via i reticolati di filo spinato. Il terzo elemento furono i reparti di fanteria che furono piccoli reparti armati di mitragliatrici, bombe a mano e lanciafiamme.
Caporetto è stata definita la più grande sconfitta mai subita dall’Esercito italiano.
La battaglia durò dal 24 ottobre al 19 novembre, ci furono numerosi episodi di panico e disordine, con soldati che si arrendevano al nemico.
Il generale Cadorna fu cacciato dal comando e venne sostituito con Armando Diaz che avrebbe guidato l’Esercito italiano fino al 1918. Ci furono tre fasi della battaglia: prima i nemici lanciarono i gas tossici; nella fase due gli austroungarici misero in campo l’artiglieria con tonnellate di proiettili; nella terza fase, ovvero l’ultima, ci fu l’impiego della fanteria.
Infine, questa disfatta divenne possibile per la mancanza di preparazione dei soldati.
Le portatrici carniche, di Beatrice M.
Tra gli atti di eroismo della Grande Guerra, vanno ricordati i percorsi delle portatrici carniche.
La Carnia era strategicamente importante perché attraverso il Passo di Monte Croce carnico, le truppe austriache potevano venire facilmente verso la pianura friulana.
Sulle postazioni erano necessari almeno novecento portatori che lavorassero per rifornire le truppe, il cui comandante militare pensò di chiedere aiuto alla popolazione allo scopo: restavano le donne, esclusi i bambini e gli anziani. Dal 1915 al 1917 furono circa 1.500 le portatrici, donne coraggiose che si esponevano al pericolo, tanto che una di loro fu uccisa dal nemico mentre riposava. Si chiamava Maria Plazer Mentil e nel 1997 è stata insignita della Medaglia d’Oro al Valore perché fu una figura simbolica che rappresentava tutte le portatrici; la sua memoria è stata celebrata anche con un monumento a Timavo.
Si svegliavano all’alba e in caso di necessità anche la notte; le donne attraversavano la valle per fare tappa ai magazzini militari dove ricevevano l’incarico di consegnare della merce ai soldati, dopodiché si incamminavano verso i versanti della montagna. La durata di ogni viaggio era compresa tra le due e le cinque ore. Il comando militare retribuiva ogni portatrice con 1,50 lire dandogli tre pasti gratuiti, una tazzina di caffè, una scodella di brodo e un piatto di pasta. Ancora desso vengono ricordate in tutto il mondo per le gesta eroiche e per il loro contributo che hanno dato nella prima guerra mondiale.
La Battaglia di Vittorio Veneto e i Ragazzi del ’99, di Giorgia S.
“Gli ultimogeniti della Madre sanguinosa”, come li definì d’Annunzio, quando scoppiò la guerra erano poco più che bambini; tre anni dopo si sarebbero ritrovati in trincea: erano i ragazzi nati nel 1899, l’ultima classe di leva italiana richiamata alle armi durante la Grande Guerra.
I primi contingenti di giovanissimi italiani, circa 80.000 minorenni, la maggiore età si raggiungeva ai 21 anni, furono chiamati all’inizio del 1917; sbrigativamente istruiti, vennero inquadrati in battaglioni di milizia territoriale.
Alla fine di maggio se ne aggiunsero 180.000 e altri, in minor numero, nel mese di luglio. Nei giorni successivi alla disfatta di Caporetto, i primi ragazzi del ‘99 furono inviati al fronte. Molti di loro ottennero di far parte dei reparti d’assalto degli Arditi, affascinati dalla loro fama di eroi senza paura.
Ebbero il battesimo del fuoco nei giorni 16 e 17 novembre 1917, al Molino della Sega sul Piave. Il loro apporto, unito all’esperienza dei veterani, si dimostrò fondamentale per gli esiti della guerra.
Infatti, le 265.000 giovanissime reclute, poco più che adolescenti, furono determinanti in un momento di gravissima crisi per il Regio Esercito, ridotto a 700.000 unità a causa delle perdite subite. Rinsaldarono le file sulla linea di resistenza del Piave e combatterono la battaglia d’arresto sul nuovo fronte, impedendo l’ulteriore avanzata austro-tedesca.
Nel 1918 diedero un apporto determinante alle decisive battaglie del Solstizio e di Vittorio Veneto.
La battaglia di Vittorio Veneto fu l’ultimo scontro tra Italia e Austria-Ungheria nella Grande Guerra.
Si combatté tra il 24 ottobre e il 4 novembre nella zona tra il fiume Piave, il Massiccio del Grappa, il Trentino e il Friuli. La fallita offensiva austro-ungarica del giugno 1918, che non era riuscita a infrangere la resistenza italiana sul Piave e sul Grappa, aveva prodotto l’irreversibile indebolimento della forza e della capacità di combattimento dell’Imperiale e Regio Esercito. La battaglia fu caratterizzata da una fase iniziale aspramente combattuta. Seguì poi un improvviso e irreversibile crollo della difesa, dovuta alla crescente disgregazione dei reparti e alle defezioni. Gli italiani riuscirono a dividere le forze austro-ungariche del Trentino da quelle del Piave, costringendo queste ultime già dal 29 novembre a ripiegare verso Vittorio Veneto.
Il 2 novembre gli italiani ripresero Rovereto e il 3 novembre Trento e Trieste. Alle ore 15 del 4 novembre 1918 le ostilità su tutto il fronte italiano finalmente cessarono.
Alle ore 15 del 4 novembre 1918 l’armistizio firmato a Villa Giusti (Padova) sancì la fine della Prima guerra mondiale.
La battaglia di Vittorio Veneto, che portò alla resa dell’esercito austro-ungarico, rappresentò – e rappresenta ancora oggi – la grande rivincita dopo la disfatta di Caporetto.
La fine anticipata del conflitto ebbe anche un’altra importante conseguenza: migliaia di vite risparmiate al fronte. Lo sapevano bene i soldati italiani che, ripreso un po’ di buonumore, commentarono il loro successo con la solita autoironia nostrana: “Proprio quando avevamo imparato a farla, la guerra è finita!”.
Anche la prima guerra mondiale ha avuto la sua meglio gioventù. La cronaca militare dell’epoca così la descriveva nell’ordine del giorno firmato dal generale Armando Diaz il 18 novembre 1917: “I giovani soldati della classe 1899 hanno avuto il battesimo del fuoco. Il loro contegno è stato magnifico”. E aggiungeva, immortalandoli per sempre: “Li ho visti i ragazzi del ’99. Andavano in prima linea cantando. Li ho visti tornare in esigua schiera. Cantavano ancora”.
“I ragazzi del ‘99”, nel 1968, per “esprimere la gratitudine della Nazione” nel cinquantenario della vittoria, vennero nominati dal Presidente della Repubblica Cavalieri di Vittorio Veneto.
La letteratura ha raccontato, con la penna di Gabriele D’Annunzio, il passaggio tremendo di un’intera generazione di adolescenti dalla famiglia alla trincea: “La madre vi ravvivava i capelli, accendeva la lampada dei vostri studi, rimboccava il lenzuolo dei vostri riposi. Eravate ieri fanciulli e ci apparite oggi così grandi!”.
Sui ragazzi del ’99 il generale Diaz aveva scritto quando li vide in azione, “Io voglio che l’esercito sappia che i nostri giovani fratelli della classe 1899 hanno mostrato d’essere degni del retaggio di gloria che su essi discende”.
A ben undici di questi soldati-ragazzini, originari di Roma, Milano, Messina, Ariano Irpino di Avellino, Riva di Trento, Firenze, Cagli di Pesaro, Longobucco di Cosenza, Novara e Lucca, cioè figli dell’Italia da quel momento libera e unita dal Brennero a Lampedusa, furono assegnate Medaglie d’Oro al Valore.
Inaugurato dalle autorità nel 1974, a Bassano del Grappa sorge il monumento nazionale che ricorda quella generazione. Fu voluto dall’associazione dei figli ormai anziani, e nipoti adulti, e loro figli.
L’ultimo “ragazzo del ‘99” è scomparso a 107 anni nel 2007. Si chiamava Giovanni Antonio Carta, caporal maggiore di Fanteria della Brigata “Sassari” e Cavaliere di Vittorio Veneto.
Gli antefatti della battaglia del Solstizio, di Michelle M.
Nel marzo 1918 il capo di Stato maggiore Arz von Straussenburg aveva rassicurato l’alleato tedesco su un’offensiva estiva in via di preparazione sul fronte italiano in appoggio strategico all’offensiva di primavera di Ludendorff sul fronte occidentale.
I rapporti tra i due imperi centrali erano da tempo conflittuali. L’Austria-Ungheria ormai era allo stremo e alle soglie della carestia alimentare, dipendeva fortemente dagli aiuti tedeschi che l’avevano salvata sul fronte orientale e avevano permesso lo sfondamento di Caporetto. Appariva però evidente anche agli alti comandi che l’intransigenza tedesca minava fortemente le possibilità di sopravvivenza dell’impero asburgico. Cominciò dunque una diatriba che vide opporsi le differenze strategiche dello Stato Maggiore dell’impero austroungarico.
Da una parte il disegno pianificato da tempo dal comandante del fronte alpino, il feldmaresciallo Conrad, che prevedeva un intervento massiccio dal tipico sfondamento delle difese italiane sull’Altipiano di Asiago e sul Monte Grappa e il proseguimento lungo la pianura del Brenta.
Il completamento della manovra sarebbe avvenuto con lo sfondamento delle difese del Monte Tomba e la discesa verso il Piave e Pederobba in direzione di Treviso, Padova e Venezia.
Dall’altra, la strategia proposta dal feldmaresciallo Borojević che prevedeva il massimo sforzo da parte delle sue armate lungo il Piave nel tentativo di sfruttare la posizione d’attacco dell’isoletta Grave di Papadopoli, nel territorio di Cimadolmo, la posizione presso Ponte di Piave dove il corso del fiume si restringe e la posa delle passerelle diventa più semplice, e infine lo sfruttamento di una situazione analoga nel territorio di San Donà di Piave.
Da parte italiana, le notizie dell’offensiva nemica erano state preannunciate dall’osservazione aerea quotidiana dell’aviazione leggera del Corpo Aeronautico e da quella dei palloni frenati, nonché dal servizio di spionaggio e dalla assidua corrispondenza dei connazionali residenti al di là del fronte effettuata attraverso piccioni viaggiatori.
Nell’aprile 1918, divennero pubblici i tentativi di Carlo I d’Austria di ottenere segretamente una pace separata nel 1917, il cosiddetto “Affare Sisto”.
I tedeschi, infuriati, nel maggio 1918 costrinsero l’Austria-Ungheria a legarsi definitivamente a loro, dandogli una posizione subordinata nella Battaglia nota come del Solstizio che gli italiani riuscirono a fermare.
Il Milite Ignoto, di Giulia Z.
Il Milite Ignoto, chiamato anche Soldato Ignoto, è un militare italiano caduto al fronte durante la prima guerra mondiale e che venne sepolto a Roma sotto la statua della dea Roma, all’Altare della Patria, al Vittoriano. La sua identità fu ignota a causa del suo corpo che venne scelto tra quelli dei caduti, privi di elementi che potevano permetterne il riconoscimento.
La sua tomba rappresenta tutti i caduti e i dispersi in guerra e nei suoi pressi si svolgono attualmente tutte le celebrazioni in occasioni di festività durante le quali il Presidente della Repubblica italiana e le varie cariche massime dello Stato rendono omaggio al Sacello con la deposizione di una corona d’alloro. La tomba fu inaugurata il 4 novembre 1921 con la traslazione da Aquileia dei resti del soldato dopo un viaggio in treno attraverso varie città italiane. Il lutto fu legato alla retorica militarista e nazionalista per il terzo anniversario della vittoria. L’anno successivo ci fu l’assunzione da parte di Benito Mussolini del ruolo di sostenitore della commemorazione che divenne uno dei simboli principali della propaganda fascista.
Antefatto della guerra italiana attraverso l’iconografia, di Hicham L.
(Lo studio è avvenuto soprattutto attraverso immagini storiche)
Le forze armate italiane
Il 3 luglio 1914 la salma del Capo di Stato maggiore del Regio Esercito, generale Alberto Pollo, entrava nella stazione di Porta Nuova a Torino, in mezzo a due ali di ufficiali in alta uniforme, diretta a Roma. Nel viaggio di accompagnamento delle spoglie del Capo di Stato Maggiore era presente anche Luigi Cadorna, che avrebbe assunto il suo incarico il 27 luglio. Appena quattro mesi prima, il generale Pollo aveva presentato una relazione in cui scriveva che se l’Esercito Italiano avesse dovuto essere posto all’altezza degli eserciti delle altre grandi potenze europee, pur tenendo conto esatto della differenza numerica esistente fra le rispettive popolazioni, sarebbe occorso compiere uno sforzo grandioso.
Le prime operazioni militari del conflitto
Videro la fulminea avanzata dell’esercito tedesco in Belgio e nel Nord della Francia, azione fermata però dagli anglo-francesi nel corso della prima Battaglia della Marna nel settembre 1914; il contrattacco dei russi da Est infranse le speranze tedesche in una guerra breve e vittoriosa e il conflitto degenerò in una logorante guerra di trincea che si replicò su tutti i fronti e perdurò fino al temine delle ostilità. A mano a mano che procedeva, la guerra raggiunse una scala mondiale con la partecipazione di molte altre nazioni come Bulgaria, Persia, Romania, eccetera. Determinante per l’esito finale fu, nel 1917, l’ingresso in guerra degli Stati Uniti d’America a fianco degli alleati anglo-francesi.
L’Italia in guerra
La partecipazione dell’Italia alla prima guerra mondiale ebbe inizio il 24 maggio 1915. Circa dieci mesi dopo l’avvio del conflitto, durante il quale il Paese conobbe grandi mutamenti politici con la rottura degli equilibri giolittiani e l’affermazione di un quadro politico rivolto a mire espansionistiche legate al fervore patriottico e a ideali risorgimentali. Inizialmente il Regno d’Italia si mantenne neutrale e parallelamente alcuni esponenti del Governo iniziarono nuove trattative diplomatiche con entrambe le forze in campo, che si conclusero con la sigla di un Patto segreto con le potenze della Triplice Intesa. La Triplice Alleanza viene abbandonata dall’Italia e dichiarò guerra all’Austria-Ungheria il 23 maggio 1915.
Il principe Amedeo di Savoia, di Christian B.
Amedeo nacque a Torino nel 1898 da Emanuele Filiberto, secondo Duca d’Aosta, e da Elena di Borbone-Orléans. Essendo erede del Ducato d’Aosta, ricevette il titolo di Duca delle Puglie. A nove anni lo mandarono in collegio a Londra dove imparò perfettamente l’inglese. Tornato in Italia a 15 anni, venne avviato alla carriera militare e iscritto ad un collegio a Napoli.
A soli 16 anni si arruolò come volontario nella prima guerra mondiale come soldato semplice, ma il padre lo fece presentare al generale Petitti di Roreto dicendo di non dargli nessun privilegio, e venne mandato in prima linea con il grado di caporale e servente d’artiglieria sul Carso, guadagnandosi poi il grado di tenente e nel 1917 quello di capitano.
Poi Amedeo si recò in Africa facendosi assumere come operaio in una fabbrica di sapone a Stanleyville.
Nel 1923 tornò in Italia dove, a Palermo, riprese la carriera militare con il grado di maggiore e, successivamente, si laureò in Giurisprudenza all’Università di Palermo.
Amedeo il 5 novembre 1927 si era sposato a Napoli con Anna d’Orléans.
A seguito della morte di suo padre, nel 1931, Amedeo diventò Duca d’Aosta. Quell’anno divenne comandante del 23° Reggimento di Artiglieria da Campagna di stanza a Torino.
Nel 1939 si era pensato di assegnargli il trono di Sardegna lasciato libero dai Borbone, ma la proposta venne rifiutata da Francisco Franco.
Dopo la seconda guerra italo-abissina, il 21 dicembre 1937 divenne governatore generale dell’Africa Orientale Italiana e Viceré d’Etiopia, contribuendo nella realizzazione di rilevanti opere pubbliche.
Il 10 giugno 1940, con l’entrata in guerra dell’Italia, diventa comandante superiore delle portaerei dell’Africa Orientale Italiana.
In confronto ai britannici, gli italiani erano inferiori sia in numero che in mezzi, perciò dovettero arrendersi il 14 maggio 1941. Poco prima della resa Amedeo, con grande legame con i giovani ufficiali, li mandò indietro nei loro villaggi e autorizzò a farlo anche gli indigeni.
Prigioniero di guerra con il numero 11590, venne portato in Kenia in aereo sul quale prese i comandi, in quanto pilota militare dal 1926. Il comando britannico non gli consentì né di visitare né di ricevere visite dagli altri italiani prigionieri. Il 26 gennaio 1942 gli venne diagnosticata la malaria e la tubercolosi e morì il 3 marzo seguente nell’ospedale di Nairobi.
Crisi e malcontento sociale, di Emanuele R.
In Italia, anche essendo la vincitrice della prima guerra mondiale, la situazione economica non fu tanto buona nel dopoguerra. C’era un fenomeno che causò maggiormente disagi alla popolazione e fu l’inflazione: il conflitto aveva costretto l’Italia a indebitarsi con i Paesi esteri e questo portò alla svalutazione della propria moneta.
Il nostro Paese prendeva molti prodotti dall’estero e a causa della svalutazione della propria moneta, la lira, i prezzi aumentarono.
Poi fecero manifestazioni spontanee contro il carovita e nel 1919 scoppiarono anche rivolte; le manifestazioni coinvolgevano operai e contadini; anche i sindacati operai chiedevano scioperi, aumenti salariali, diminuzione dell’orario di lavoro, mentre i contadini protestavano contro la mancata assegnazione delle terre promesse prima della guerra, che portò all’occupazione delle terre incolte. Ci fu anche il problema della disoccupazione che toccava molti settori. All’inizio le industrie fecero armi per l’esercito, ma poi licenziarono il personale alla fine del conflitto.
In Puglia si formarono leghe di contadini di tipo sindacale. Gli impiegati erano in una situazione simile a quella degli operai, anche loro colpiti dall’aumento dei prezzi. Gli impiegati erano organizzati in sindacati e ritennero di avere una posizione sociale di più alta qualità rispetto a quella degli operai e dei contadini. Non a caso, a differenza degli operai e dei contadini, nel dopoguerra tra il ceto medio si diffusero posizioni politiche fortemente conservatrici.
Le scelte politiche italiane 1920-1921, Luca A.
Tra il 1919 e il 1920, nel periodo che passò alla storia con il nome di biennio rosso, le organizzazioni sindacali e i movimenti operai diedero vita a una lunga serie di scioperi, che coinvolsero molte grandi città, soprattutto nel Nord del Paese come Torino, Milano e Genova, dove erano nate grandi industrie quali la Fiat, la Pirelli e l’Ansaldo. Altri moti vedono in piazza ex ufficiali, piccoli e medi borghesi ridotti in povertà dall’inflazione. Anche nelle campagne la situazione è drammatica: nel Sud si chiede che siano distribuite le terre come promesso nella fase finale e più difficile della guerra.
Al Nord le fabbriche sono occupate dagli operai e gli industriali vorrebbero che il Governo le sgomberasse con forza. Presieduto da Giovanni Giolitti, il Governo non volle rischiare però un conflitto fra borghesia e proletariato, che avrebbe potuto spianare la strada a una vera e propria rivoluzione, e decise di temporeggiare fino al naturale esaurimento del movimento.
Nel 1919 si svolgono le elezioni. I liberali perdono la maggioranza assoluta. Ottengono buoni risultati i socialisti e i cattolici, che hanno fondato il Partito Popolare (ispiratore e segretario è il sacerdote siciliano Luigi Sturzo).
Il programma dei popolari è basato sui valori della religione, della famiglia, sul rispetto per la proprietà privata e sulla libera iniziativa. Compare il movimento fascista di Benito Mussolini che propone riforme a favore delle classi popolari, ma presto si schiera al fianco di industriali e proprietari terrieri. Da una discussione dei socialisti nasce nel 1921 il Partito Comunista d’Italia. Nessun partito dopo le elezioni ha potuto formare un governo stabile e nel 1921 si torna a votare. I fascisti fanno leva sui motivi di malcontento e sulla paura del comunismo di industriali e agrari. Ottengono però scarsi risultati e per imporsi usano la violenza, con squadre di picchiatori contro i socialisti e i sacerdoti che simpatizzano con i lavoratori. Il governo liberale non è capace di fronteggiare Mussolini che comincia a farsi chiamare Duce.
Il viaggio da Aquileia a Roma, di Alexander G.
Il 2 novembre 1921, alla presenza del re d’Italia Vittorio Emanuele III e di tutta la famiglia reale, faceva il suo ingresso nella stazione Termini di Roma il Treno della Memoria partito da Aquileia, che trasportava i resti di un combattente italiano rimasto senza identità, eretto a simbolo di tutti i caduti durante la prima guerra mondiale. Così si iniziava l’ultima parte del viaggio del Milite Ignoto che il 4 novembre 1921 veniva sepolto con grandi onori nell’Altare della Patria. Sono passati cent’anni e questa figura legata a un’epoca di ragazzi, padri e persone comuni che combattevano e morivano per un’ideale di libertà, ha percorso un viaggio nella memoria toccando gli stessi punti del viaggio originale due anni dopo la fine della prima guerra mondiale, quando nacque un’idea di un riconoscimento alle migliaia di soldati caduti o dispersi durante il sanguinoso conflitto che costò all’Italia circa 1.240.000 morti fra militari e civili, il 3,4 per cento della popolazione del momento.
Undici salme di soldati impossibili da identificare vennero recuperate da altrettante zone in cui si svolsero i diversi conflitti: Rovereto, Colle Grappa, Conegliano, solo per citarne alcune. I resti vennero messi in undici bare identiche e portati nella Basilica di Aquileia, dove la madre di un soldato disperso avrebbe scelto fra esse quale sarebbe effettivamente divenuta il simbolo del Milite Ignoto. Fu Maria Maddalena Blasizza di gradisca d’Isonzo, madre del maestro comunale Antonio Bergamas, di cui era stato impossibile individuare i resti che erano stati tumulati in un cimitero successivamente devastato da un bombardamento.
Ho ricavato queste notizie da un libro e da un’applicazione del cellulare.
Le celebrazioni del 4 novembre 1921, di Eliezer A.
Le solenni celebrazioni del 4 novembre 1921 in onore del Milite Ignoto hanno rappresentato, secondo alcuni studiosi, il rafforzamento, da parte degli italiani, di quello spirito patriottico che era stato messo più volte a dura prova dalle innumerevoli sofferenze patite durante la prima guerra mondiale.
Quella che il popolo italiano vive nelle intense giornate del viaggio del Milite Ignoto da Aquileia a Roma è una vera e propria manifestazione di sacralità laica e di orgoglio nazionale, in cui la devozione verso Dio e verso la Patria si fondono in un unico rito collettivo, generando tra la gente comune un’apoteosi del sentimento patrio e del processo di sacralizzazione della nazione.
Subito dopo la commovente inumazione della salma nel loculo posizionato sotto la statua della dea Roma, al Vittoriano, che da quel momento sarà per tutti gli italiani anche l’Altare della Patria, diventa luogo di un incessante pellegrinaggio da parte delle migliaia di persone giunte nella capitale per assistere all’evento. A rendere gli onori ufficiali alla lapide arriveranno anche il generale americano Henry Truman Allen, l’ammiraglio inglese sir Charles Madden, il Re del Belgio, il presidente dell’Argentina Marcelo Torcuato de Alvear e varie delegazioni militari.
La giornata patriottica che si svolse il 4 novembre 1921, però, non vide protagonista solo la città di Roma. Con la circolare diramata il 30 settembre, infatti, il Ministero della Guerra aveva affidato ai comandi di Corpo d’Armata territoriali il compito di organizzare per quel giorno, e nello stesso momento in cui a Roma sarebbe stata data sepoltura alla salma del Milite Ignoto, “Solenni onoranze “.
Come testimoniano gli album fotografici, la mobilitazione e la partecipazione popolare furono massicce in tutta Italia. In seguito alla partenza da Aquileia della salma di Antonio Bergamas, le dieci salme rimaste nella Basilica vennero sorvegliate per alcuni giorni da un picchetto d’onore fino alla mattina del 4 novembre, quando vennero celebrate le esequie da monsignor Celso Costantini, che recitò una preghiera di assoluzione nel piazzale antistante alla Basilica, mentre le salme vennero portate a spalla nel cimitero degli Eroi dietro alla chiesa.
La celebrazione del Valore. Il centenario del Milite Ignoto, di Issmail O.
Un secolo fa, l’Altare della Patria di Roma, nel monumento eretto in Piazza Venezia in onore di re Vittorio Emanuele II, detto il Vittoriano, divenne protagonista del ricordo del militare ignoto. Infatti, il 4 novembre 1920 era prevista la festa delle bandiere, il raduno di tutti gli stendardi dei vari reparti militari che avevano combattuto durante la Grande Guerra da poco conclusasi. Era un anno difficile, perché la fatica della guerra aveva prostrato tutti, ma la conclusione del conflitto non aveva portato il benessere sperato. C’era disoccupazione, fame, malattie e proteste nel cosiddetto biennio rosso. La “vittoria mutilata” aveva creato scontento. La prima bandiera ad arrivare a Roma fu quella dei Granatieri di Sardegna: le partenze delle bandiere dalle varie località aveva dato adito ad ulteriori disordini, ma al Vittoriano arrivarono ben 335 bandiere che sfilarono davanti ai reali che si inchinarono al loro passaggio. Lo spettacolo fu superbo davanti alla folla accorsa, al Re, al Duca d’Aosta, al generale Armando Diaz, le molte autorità e gli ex-combattenti.
Il ricordo degli assenti e della sofferenza fu molto toccante.
Serviva un soldato a rappresentarli tutti, quei caduti senza tomba, pertanto un Disegno di Legge divenne necessario per porre una croce e dire una preghiera sulle molte tombe senza riferimenti o per i molti dispersi del conflitto. Il Governo approvò l’idea di trovare anche per l’Italia, come per la Francia e la Gran Bretagna, un Milite Ignoto che una Commissione apposita trovò e condusse alla celebrazione del 4 novembre dell’anno successivo.
Le celebrazioni del valore. Il centenario del Milite Ignoto, di Paolo R.
Il 4 novembre 2021 si celebra il centenario del Milite Ignoto, celebrato come importante gesto simbolico promosso dal gruppo delle Medaglie d’Oro al Valore Militare d’Italia dall’ANCI.
Il 4 novembre ricorre anche la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Le celebrazioni hanno visto il 13 novembre anche la cerimonia della scopertura del busto marmoreo in memoria delle Medaglie d’Oro al Valor Militare.
La storia delle celebrazioni al valore inizia un secolo fa, a Roma, presso il monumento in Piazza Venezia in onore di re Vittorio Emanuele II, monumento detto il Vittoriano protagonista della prima celebrazione; infatti il 4 novembre 1920 ci doveva essere la festa delle bandiere, un incontro di soldati della Grande Guerra da poco conclusa. Era un anno duro dalla fine della guerra: tanti licenziamenti, fame, malattie e proteste. Anche la “vittoria mutilata” non aveva portato un buon animo negli ex combattenti, e c’erano stati anche molti suicidi. Il 4 novembre 1920 si inchinarono ben 335 persone davanti al Re, con lanci di fiori.
Il 30 settembre 1921 arrivò una circolare che emanava come il 4 novembre 1921 si sarebbe sepolta la salma del Milite Ignoto a Roma, presso l’Altare della Patria, come momento di unità collettiva. La salma ignota perché così non si poteva risalire alle sue generalità, perché fosse simbolo di tutti i combattenti e di tutti i caduti che non avevano nemmeno avuto degna sepoltura.
Fino al 1921 non si vide la fine delle sofferenze per l’Italia; poi venne nominata una Commissione deputata a cercare 11 salme come richiesto proprio dalla circolare n. 7. I suoi membri avevano giurato di tacere per sempre sui luoghi di ricerca dei caduti. Nel 1921 passando per il Monte Grappa, il Montello, cercando anche un marinaio simbolo della Marina, si cercarono le salme tra le quali una donna, il 28 ottobre 1921, riconosce idealmente suo figlio Antonio come Milite Ignoto. Esso e “La leggenda del Piave” divennero emblema nazionale e lo sono ancora oggi.
La tomba del Milite Ignoto, di Reidi G.
La tomba del Milite Ignoto è una tomba simbolica che contiene i resti di un militare morto in guerra, il cui corpo non è stato identificato e che si pensa non potrà mai essere identificato. La pratica di avere una tomba del Milite Ignoto si è diffusa soprattutto sopo la prima guerra mondiale, una guerra il cui numero di corpi non identificati fu enorme.
Nel 1920, l’allora colonnello Giulio Douhet sulla scorta di analoghe iniziative già attuate in Francia e in altri Paesi coinvolti nella Grande Guerra, propose per primo in Italia di onorare i caduti italiani le cui salme non furono identificate. Quell’idea era nata in Inghilterra e in Francia; quella cosa fu abbastanza simile in tutte le nazioni che avevano combattuto.
Fu quindi deciso ci creare la tomba del Milite Ignoto a Roma, nel complesso monumentale del Vittoriano in Piazza Venezia, sotto la statua della dea Roma dove sarebbe stata tumulata la salma di un soldato sconosciuto, selezionata tra quelle dei caduti della prima guerra mondiale.
Quella scelta fu affidata a Maria Bergamas, madre di Antonio Bergamas, che aveva disertato dall’esercito austriaco per unirsi a quello italiano dove cadde in combattimento e il suo corpo non venne trovato. La bara prescelta fra le undici, il 26 ottobre 1921, nella Basilica di Aquileia, fu collocata sull’affusto di un cannone e, accompagnata da reduci decorati al Valore e più volte feriti, fu deposta su un carro ferroviario appositamente disegnato. Le altre dieci rimasero ad Aquileia sepolte dietro al tempio di epoca romana.
La cerimonia ebbe il suo epilogo nella capitale. Tutte le rappresentanze dei combattenti e delle vedove e delle madri dei caduti, con il Re in testa e le bandiere di tutti i reggimenti, mossero incontro al Milite Ignoto che fu portato da un gruppo di decorati di Medaglia d’Oro a Santa Maria degli Angeli.
La salma venne posta nel monumento il 4 novembre 1921. L’epigrafe riporta la scritta “Ignoto Militi” e le date MCMXV e MCMXVIII, l’anno di inizio e l’anno della fine del conflitto.
Negli anni ‘30 il feretro del Milite Ignoto venne traslato nelle cripta interna del Vittoriano, dove tuttora si trova, denominata Sacello del Milite Ignoto.
Parti della cripta e del sepolcro sono realizzate con materiali lapidei provenienti dalle montagne teatro degli scontri della prima guerra mondiale.
Giulio Douhet, di Valter T.
Giulio è nato a Caserta il 30 maggio 1869 in una buona famiglia, patriottica. Scelse la carriera delle armi, quindi frequentò il collegio militare di Firenze nel 1882, all’età di 13 anni; nel 1886 entra nell’Accademia di Applicazione d’Artiglieria e Genio.
Divenne tenente d’Artiglieria nel 1890, prestò servizio in vari Reggimenti, frequentò corsi della Scuola di Guerra e fu promosso capitano nel 1900. Contemporaneamente seguiva corsi di elettrotecnica e dava alle stampe studi sulle applicazioni delle basse temperature, sui motori a campo rotante e, tra il 1910 e il 1904 sulle applicazioni militari dell’automobilismo.
Nel 1910 fu promosso maggiore e decorato della Croce di Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia. Nello stesso anno pubblica sul giornale “La Preparazione” sei articoli sui problemi dell’aeronavigazione che aprirono un dibattito sulle possibilità di sviluppo dell’aviazione e il suo impiego militare.
Il suo interessamento alla nuova specialità che era l’aviazione fece sì che nel 1912 venne assegnato come comandante in seconda al Battaglione aviatori di nuova creazione in Torino, che riuniva tutti gli aeroplani dell’Esercito, con il compito di promuovere lo sviluppo tecnico e industriale, curare l’addestramento del personale e studiare l’utilizzazione bellica della nuova arma.
Nel 1913 assunse il comando del Battaglione e nel 1914 viene promosso a tenente colonnello. A seguito di tensioni con i suoi superiori, sempre nel 1914, si dimette dal servizio lamentandosi sui limiti della gestione dell’Aeronautica militare.
Nel 1917 viene richiamato in servizio come capo della Direzione Generale di Aviazione di nuova costituzione che aveva il compito di curare lo sviluppo delle costruzioni aeronautiche ed, in particolare, la creazione di una flotta di 3.500 aeroplani da bombardamento, che avrebbe dovuto dare all’aviazione italiana la potenza distruttrice per cui Giulio si era sempre battuto. Tuttavia fu un progetto irrealizzabile per le limitazioni delle industrie del tempo e divenne un fallimento. Il 4 giugno 1918 Douhet presenta le sue dimissioni e lasciò l’Esercito, finendo qui la sua carriera militare. Scrisse numerosi testi su riviste e periodici tra cui il più significativo fu il volume “Come finì la Grande Guerra. La Vittoria alata” in cui egli immaginava che le potenze dell’Intesa, accogliendo le sue intuizioni, avessero dato vita a un’armata aerea inarrestabile, capace di risolvere da sola il conflitto in pochi giorni, con la conquista del dominio dell’aria e il bombardamento massiccio delle maggiori città austro-tedesche.
Nell’agosto 1920 lanciò la proposta di erigere nel Pantheon romano una tomba al Milite Ignoto. L’idea di Douhet varcò i confini nazionali e iniziative furono prese in altri Paesi coinvolti nella prima guerra mondiale. La proposta venne accolta con entusiasmo dall’onorevole Cesare Maria De Vecchi, capitano del Regio Esercito durante la Grande Guerra, il quale presentò in Parlamento un Disegno di Legge per la costruzione di un monumento per tutti i soldati morti in guerra.
Il Decreto sulla “Sepoltura della salma di un soldato ignoto” venne approvato dal Parlamento del Regno d’Italia il 4 agosto 1921 all’unanimità e senza dibattito. Come luogo della sepoltura fu scelto il Vittoriano. La scelta era motivata soprattutto dalla volontà dell’autorità politica di assegnare al Vittoriano un nuovo ruolo, unendo alla celebrazione e commemorazione del primo Re d’Italia anche quella dei caduti in guerra.
Il Vittoriano è un monumento costruito dopo la morte del primo Re d’Italia inaugurato nel 1911 da Vittorio Emanuele III, nipote di Vittorio Emanuele II. Fu costruito per celebrare l’intera stagione risorgimentale.
Elaborati della Classi III
Il Milite Ignoto. Approfondimento su Maria Bergamas di Giulia B.
La Commissione incaricata di designare quale madre dovesse divenire “mamma spirituale del Milite Ignoto” inizialmente fece ricadere la sua scelta su Anna Venturini Feruglio, udinese, madre di due figli dispersi in guerra, alla quale si preferì poi una popolana, Maria Bergamas di Trieste, il cui figlio irredento era per lei il suo massimo sostegno e speranza.
Maria Maddalena Bergamas, nata a Gradisca d’Isonzo il 23 giugno 1867, visse a Trieste dove si era trasferita in gioventù e dove risiedeva allo scoppio della Grande Guerra.
Ella era vedova e quando suo figlio Antonio fu arruolato non ebbe più nessun sostegno per lei e la figlia Anna.
È stata la donna italiana che fu scelta in rappresentanza di tutte le madri italiane che avevano perso un figlio durante la prima guerra mondiale, del quale non erano state restituite le spoglie. Maria morì poi il 22 dicembre del 1953 a Trieste.
Al tempo dello scoppio della guerra, sia Gradisca d’Isonzo che Trieste erano parte dell’impero austro-ungarico, perciò suo figlio Antonio fu arruolato nell’esercito austriaco. Egli era ricordato per il suo impeto e la sua passione politica e ai primi segnali di guerra tra Austria e Italia, nel 1916, disertò, varcò clandestinamente il confine, fuggì in Italia e si arruolò volontario nel 137° Reggimento di Fanteria della Brigata Barletta, con il nome fittizio di Antonio Bontempelli, una falsa identità imposta dal Regio Esercito per accogliere tra le sue file gli irredentisti (coloro che hanno aiutato il riscatto dalla dominazione straniera).
Mentre guidava l’attacco del suo plotone, durante un combattimento alle falde del Monte Cimone di Tonezza, il 18 giugno 1916 (alcune fonti citano il 16 giugno), il sottotenente Bergamas fu raggiunto e ucciso da una raffica di mitraglia.
Al termine della battaglia, nelle sue tasche fu trovato un biglietto nel quale si pregava di avvisare della sua morte il sindaco di San Giovanni di Manzano, l’unica persona al corrente della sua reale identità. La salma di Antonio Bergamas fu dunque riconosciuta e sepolta assieme agli altri caduti nel cimitero di guerra di Marcesina, sull’Altopiano dei Sette Comuni.
Tuttavia, a seguito di un violento bombardamento che distrusse il cimitero, Bergamas e i suoi compagni con lui sepolti risultarono ufficialmente dispersi.
Dopo la guerra, Maria ebbe l’incarico di scegliere il corpo di un soldato tra undici salme di caduti non identificabili, raccolte in diverse aree del fronte.
Il 28 ottobre 1921, nella basilica di Aquileia, in Friuli Venezia-Giulia, la donna fu posta di fronte alle indici bare allineate: appoggiò lo scialle sulla seconda bare e, dopo essere passata davanti alle prime, non riuscì a proseguire e si accasciò al suolo davanti alla decima, urlando il nome del figlio; per questo motivo fu scelta quest’ultima.
La salma prescelta fu posta all’interno del Monumento al Milite Ignoto, presso il Vittoriano a Roma, a ricordo dei caduti della guerra, e la cerimonia solenne avvenne il 4 novembre 1921, dopo il lungo viaggio in treno rallentato per permettere a tutta Italia di rendere onore alla bara.
Secondo la testimonianza della figlia, Maria era decisa a scegliere l’ottava o la nona bara, poiché quelli erano i numeri che ricordavano la nascita e la morte del figlio, ma giunta dinanzi alle bare provò un senso di vergogna e, poiché nulla dovesse ricordare suo figlio, scelse la decima, affinché il simbolo che si sarebbe portato a Roma fosse davvero un soldato ignoto.
L’anno successivo alla morte di Maria, il 3 novembre 1954, la sua salma fu riesumata e sepolta nel cimitero di guerra di Aquileia, retrostante la Basilica, vicino ai corpi degli altri militi ignoti, come da lei richiesto, per sentirsi più vicina al figlio.
A Gradisca d’Isonzo, in Via Bergamas 39, esiste ancora la casa dove Maria e i figli abitarono. Una targa ricorda: “In questa casa nacque Antonio Bergamas che irradiata la giovinezza dell’ideale di Mazzini il XVIII giugno MCMXVI nel nome santo d’Italia suggellava sul Cimone la sua fede col sangue”.
Ho scelto di approfondire questo argomento perché mi interessa conoscere le persone della storia, coloro che la storia l’hanno fatta. Penso sempre al fatto che dietro a un personaggio c’è una persona e approfondirne la vita è, per me, molto interessante. Questo lavoro mi ha fatto conoscere nuovi termini relativi alla guerra, mi ha fatto approfondire parti di storia che normalmente non vengono studiate e mi ha lasciato la voglia di scoprire sempre di più, e di visitare i luoghi citati nel tema. Ho apprezzato lo svolgimento di questo compiti e penso mi piacerebbe affrontarne altri simili.
Il rito del Milite Ignoto di Asia Z.
Non si volevano celebrare condottieri, generali o singoli comandanti, ma glorificare il sacrificio di sangue di un intero popolo.
In Italia la proposta di glorificare la salma del caduto senza nome viene sostenuta e resa pubblica nell’agosto 1920 dal colonnello Giulio Douhet. Il 4 agosto il Disegno di Legge arrivò in aula e l’onorevole Gasparotto chiese alle parti di rinunciare ad intervenire perché il provvedimento che rendeva onore ai caduti potesse essere approvato in silenzio. Fu Gabriele D’Annunzio a dare il nome di “Milite Ignoto” alla salma del soldato senza nome, che nel tempo avrebbe ricordato i sacrifici e gli eroismi della Grande Guerra. Il soldato che avrebbe rappresentato tutti coloro che non fecero più ritorno a casa. Tutte le famiglie italiane erano coinvolte: chi per aver perso un figlio, chi un marito, chi un padre.
Dal 3 al 24 ottobre 1921 iniziò la ricerca delle undici salme di soldati tra i quale scegliere il Milite Ignoto. I corpi vennero rinvenuti nei cimiteri militari o nei campi di battaglia e per essere scelti non dovevano in nessun modo mostrare alcun segno di riconoscimento. Il 28 ottobre 1921 le undici casse con i resti dei dispersi vennero trasportate nella Basilica di Aquileia e nella notte scambiate in segreto di posto, perché chi ne aveva seguito il viaggio per un mese sarebbe stato ormai in grado di riconoscerle.
Il giorno dopo sarebbe avvenuta la scelta di una di loro tramite la signora Maria Bergamas, moglie, madre, donna, e sarebbe iniziato così il viaggio verso Roma del Treno dell’Eroe con le spoglie del Milite Ignoto.
Il 28 mattina le porte della Basilica vennero aperte, le undici bare erano avvolte nel Tricolore. Le madri e le vedove presero posto in un palco alla destra dell’altare. All’arrivo di Emanuele Filiberto di Savoia, Duca D’Aosta, iniziò la celebrazione.
Al finire della funzione quattro decorati con Medaglia d’Oro al Valore Militare si diressero verso le madri e le vedove per accompagnare la signora Bergamas a compiere l’atto più importante di tutta la cerimonia.
Il generale Paolini e l’onorevole Paolucci accompagnarono la donna all’altare che, dopo aver guardato le altre madri, iniziò il suo cammino verso la scelta. Giunta di fronte alla decima bara, la donna lanciò un urlo chiamando per nome suo figlio Antonio e abbracciando con passione la cassa. Il rito era compiuto e Maria Bergamas venne riaccompagnata fra le altre madri, mentre la bara scelta fu posta su un rialzo di fronte all’altare, inserita in una cassa mandata dal Ministero della Guerra.
Ho scelto di approfondire questo argomento in quanto sono appassionata di riti di ogni tipo, quindi il rituale del Milite Ignoto mi sembrava la parte più interessante dell’intero argomento dedicato a questo centenario. Grazie a questa ricerca ho potuto imparare una nuova piccola parte della storia del nostro Paese, in quanto non sapevo esistesse un monumento in memoria dei caduti senza nome. Penso che sia stata una celebrazione molto toccante ed importante, considerando che è riuscita ad unire un intero popolo.
Da Gorizia ad Aquileia di Siria G.
Il mattino del 27 ottobre 1921, nella piazza di Gorizia, si formò un corteo per il trasporto delle undici bare degli ex-combattenti portati a spalla fino alla stazione ferroviaria per poi essere adagiate sui ripiani degli autocarri. Le bare erano sommerse da corone di fiori per omaggio. I mezzi partirono da Gradisca d’Isonzo fino a Cervignano con omaggi dati dai cittadini. Le bare erano portate da madri, ex-combattenti e madri vedove di guerra che attraversarono la piazza di Aquileia. Una volta attraversata la piazza, le bare che erano avvolte da una bandiera tricolore, vennero messe ai lati dell’altare della Basilica, 6 a destra e 5 a sinistra. Sulla bandiera tricolore veniva posato un elmetto in ferro da fante. Una volta sgomberata la piazza, le bare degli ex-combattenti venivano cambiate di posto perché, data la perfetta somiglianza delle bare, le linee degli assi di legno e la posizione dei chiodi era diversa l’una dall’altra, quindi potevano essere riconosciute dai membri della Commissione che le vedevano da giorni. Le casse erano sorvegliate per l’intera notte da due plotoni, uno dei reali Carabinieri mentre l’altro era di fanti della Brigata “Sassari”.
Penso che questo gesto verso il Milite Ignoto che sta a rappresentare tutti i combattenti caduti in battaglia, sia un gesto di grande onore verso le famiglie che purtroppo non hanno più visto i propri figli dopo la guerra. Vorrei ringraziare chi in passato ne ha avuto l’idea perché è un gesto reso indimenticabile.
Il Milite Ignoto di Elisa S.
Il tema che sto per scrivere riguarda l’argomento del Milite Ignoto nel centenario della sua sepoltura al Vittoriano. Mi ha portato a scrivere questo tema la considerazione di un uomo eroe di guerra, coraggioso di combattere nelle più brutali e cruente battaglie e resistere nelle terrificanti trincee e morire durante il combattimento della guerra per la vittoria della propria Patria ed essere degno di aver combattuto per amore della propria Patria.
Al Milite Ignoto fu assegnata una Medaglia d’Oro nel complesso del Vittoriano all’Altare della Patria, a Roma, il giorno 4 novembre 1921, monumento al primo re d’Italia Vittorio Emanuele II inaugurato il 4 giugno 1911. Il corpo di quel soldato anonimo dopo la guerra diviene parte della memoria nazionale.
L’altare del Vittoriano venne definito un luogo per la storia di un’intera comunità, lasciando un percorso iniziato nel 1915 per i soldati partiti per la guerra.
Nel novembre 1921 ci fu la “tradotta di gloria”, usata per le risorse verso i fronti di guerra dei soldati, adoperata per trasportare il Milite Ignoto. Ci fu l’evento definito della ”sacra salma” che fu un viaggio rituale partito da Aquileia fino a Roma; un evento che venne ripreso dalla camere dei cinegiornali e che rappresenta il primo dopoguerra italiano.
Nel corpo del Milite Ignoto viene fissata una particolare memoria della nazione. Una memoria per le migliaia di persone, i cortei, le corone di fiori e le dimostrazioni militarti che era destinata a fissarsi al Vittoriano.
Questo monumento serve per simboleggiare il lutto in modo che non si lasci spazio alle opposizioni sociali e alla vendette politiche alla causa del dolore e della rabbia per le molte mancanze subite. La guerra era ormai finita, ma con ancora necessità di ricostruire il Paese con generazioni di uomini mancanti, povertà, disoccupazione.
L’Italia assunse il Milite Ignoto come un campo di prova per la ricostruzione del mito nazionale.
Al cadavere del Milite Ignoto venne dato il compito di legare il corpo di migliaia di soldati in lutto attraverso la sacralizzazione del sangue.
C’è il luogo della matrilinearità che serve per scegliere la “sacra salma” del “figlio degno” che è stato assegnato alla vedova Maria Bergamas, una delle donne d’Italia addolorate. Il funerale del corpo del Milite Ignoto venne fatto per le vie d’Italia e poi seguito in corteo a Roma per dare pace a tutti coloro che avevano sofferto.
Da questo tema ho imparato che un uomo ha preferito sacrificare la propria vita per il bene della Patria; quell’uomo è stato orgoglioso di combattere per amore della Patria.
Ho imparato che per ottenere una vittoria bisogna fare dei sacrifici.
Aquileia di Giulia M.
Aquileia venne fondata nel 181 a.C. come colonia romana e come postazione offensiva per le operazioni militari contro i Galli, ed ebbe inizialmente la struttura del presidio militare. Aquileia acquistò importanza come emporio commerciale, che corrispose all’ampliamento dell’antico abitato, dotato di un porto fluviale e di splendidi edifici. Abili artigiani erano maestri di oreficeria, lavoravano il vetro e la terracotta, il marmo e la pietra, e realizzarono mosaici di particolare bellezza. Con l’imperatore Diocleziano divenne una delle città più grandi dell’impero Romano. Nel frattempo si formò una comunità cristiana. Il vescovo Teodoro fece costruire un complesso per il culto.
Da visitare:
- La basilica
- Il museo archeologico
- Il campanile
Il viaggio del Milite Ignoto di Ilaria B.
Alle otto del mattino del 29 ottobre 1921 partì, dalla stazione di Aquileia un treno che entrò nella storia d’Italia. Si trattava del convoglio che, in cinque giorni, avrebbe portato la salma del Milite Ignoto a Roma per essere sepolta all’interno del Vittoriano il 4 novembre.
Un viaggio emozionante attraverso cinque regioni e centoventi stazioni, dove centinaia di migliaia di persone lungo i binari resero omaggio a quel corpo senza nome, simbolo del sacrificio per amore della Patria. Un viaggio accolto con entusiasmo e partecipazione. Il cerimoniale, proposto nell’agosto 1920 dal colonnello Giulio Douhet, ebbe come momento centrale la scelta della bara, avvenuta il 28 ottobre 1921 nella basilica di Aquileia. Protagonista fu Maria Bergamas, una donna che aveva perso un figlio durante la guerra. Sorretta da quattro militari, Maria aveva in mano un fiore bianco che avrebbe dovuto gettare su una delle undici bare contenenti i resti dei corpi ritrovati in undici luoghi simbolici della Grande Guerra (Rovereto, l’Altopiano di Asiago, Monte Grappa, Dolomiti, Montello, Basso Piave e Cadore).
Davanti alla bara prese il suo velo nero e lo appoggiò sopra, segnalando così la sua scelta. Il feretro venne così collocato sulla base d’appoggio di un cannone trainato da cavalli addobbati a lutto e, seguita da un corteo di reduci e cittadini, posta in un vagone ferroviario. Contemporaneamente le altre dieci bare furono portate all’interno del cimitero degli Eroi di Aquileia, dietro la basilica di Santa Maria degli Angeli, in cui trovò posto anche Maria Bergamas nel 1952.
Ho scelto di svolgere questa ricerca perché ero curiosa di sapere come la gente avesse accolto l’arrivo del Milite Ignoto.
Ho imparato che Maria Bergamas è stata una donna molto forte, perché, nonostante avesse perduto suo figlio, è riuscita a riconoscere la bara del Milite da onorare per tutti.
Da Aquileia a Roma. Il viaggio del Milite Ignoto di Christian G.
Il 28 ottobre 1921, alla stazione di Aquileia, la bara del Milite Ignoto, scelta dalla signora Maria Bergamas, fu posta su un carro ferroviario su un affusto di cannone, disegnato appositamente da Guido Cirilli; su un lato erano scritte la date MCMXV-MCMXVIII (1915-1918); invece sul lato opposto era riportata la citazione dantesca: “L’ombra sva torna ch’era dipartita”.
Il treno partì la mattina seguente, il 29 ottobre del 1921, alle ore otto. Oltre al carro con la bara, erano presenti 15 carri per raccogliere le corone di fiori lanciate dai cittadini, durante il tragitto; le altre carrozze di prima e di seconda classe erano destinate alla scorta d’onore. Il treno si fermava in ogni stazione cinque minuti ed effettuò in tutto 120 soste.
Il Ministero della Guerra ordinò il più rigoroso silenzio durante il passaggio del treno; erano vietati discorsi pubblici e all’arrivo nelle stazioni poteva essere suonata una sola volta “La canzone del Piave”.
Durante le fermate notturne a Venezia, Bologna e Arezzo era predisposto il cambio alle rappresentanze di senatori, di deputati, di madri, di vedove, di mutilati e di ex combattenti.
Per la trazione erano utilizzate due locomotive FS740. I macchinisti furono scelti tra i decorati di guerra, cioè persone ritenute eroiche e che avevano ottenuto medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. Durante il passaggio del treno, la folla si inginocchiava; le donne e i bambini lanciavano i fiori; il saluto militare da parte di rappresentanze delle forze armate e di ex combattenti, le autorità religiose locali benedivano la salma. I fiori furono lanciati dal treno nelle acque del Piave, celebrando i caduti, al passaggio. La destinazione del viaggio fu la stazione di Portonaccio, la sera del primo novembre. La mattina seguente era previsto l’arrivo alla stazione di Roma Termini per le successive celebrazioni.
La mattina del 2 novembre, quando la bara del Milite Ignoto giunse alla stazione di Roma Termini, fu accolta dal Re e dalla famiglia reale, da bandiere, stendardi e insegne militari dell’Esercito, della Marina e della Guardia di Finanza, con generali, comandanti d’armata, capi di Stato maggiore dell’Esercito e della Marina. Erano invitati, insieme alle diverse cariche dello Stato, decorati di medaglia d’oro e rappresentanze di mutilati, di madri e vedove di caduti e di ex combattenti.
La bara, sostenuta dall’affusto di cannone, fu trasportata alla basilica di Santa Maria degli Angeli, affiancata da decorati della medaglia d’oro e seguita a piedi dal re Vittorio Emanuele III e dalle cariche dello Stato. In Piazza Esedra la bara del Milite Ignoto fu benedetto dal vescovo monsignor Angelo Bartolamasi e poi portata all’interno della Basilica a spalla, posta su un palco per la cerimonia.
La bara rimase nella chiesa fino al 4 novembre con un gruppo di soldati d’onore: quattro ufficiali, quattro sottufficiali, quattro caporali, quattro soldati, quattro mutilati e quattro ex combattenti. Durante il giorno la chiesa fu aperta al pubblico per permettere di rendere omaggio al caduto.
Il 4 novembre, terzo anniversario della fine della prima guerra mondiale, alle ore 8 e trenta, la bara fu caricata sull’affusto di cannone. Il lungo corteo delle varie armi di Esercito, Marina, Guardia di Finanza e Guardia di Pubblica Sicurezza, precedeva il carro seguito a sua volta da dieci madri e da dieci vedove di caduti, da rappresentanti di cariche dello Stato e dell’Esercito e dalla rappresentanza di mutilati ed ex combattenti.
All’Altare della Patria attendevano l’arrivo del corteo il re Vittorio Emanuele III con la famiglia reale e le più alte cariche dello Stato, insieme a rappresentanze di vedove di caduti in guerra, di grandi mutilati, di associazioni e di ex combattenti. Il corteo giunse alle 9 e trenta riempiendo la Piazza Venezia; la bara fu portata a spalla fino alla tomba e sepolta sotto la statua della dea Roma, all’Altare della Patria, o Vittoriano, con il saluto militare.
Grazie a questo argomento ho capito cosa è successo dopo la prima guerra mondiale e ho approfondito la mia conoscenza personale. Poi ho compreso che con quest’azione, il viaggio del Milite Ignoto, lo Stato italiano si interessava della popolazione italiana, rendendo omaggio ai caduti in guerra. Infine ho trovato questa ricerca utile e interessante per i motivi descritti in precedenza.
Maria e Antonio Bergamas di Aman M.
Maria Bergamas abitava a Trieste e in quel periodo la città apparteneva agli Austriaci. Maria era stata scelta per rappresentare tutte le madri che avevano perso il figlio durante le battaglie della Grande Guerra. Antonio era l’unico uomo di casa perché Maria era vedova. Antonio faceva parte dell’esercito austriaco perché non aveva altra scelta. Nel 1916 scappa da Trieste ed entra in Italia sotto la falsa identità di Antonio Bontempelli, un uomo morto per la Patria durante la guerra e che era sepolto nel cimitero di Mercesina al Monte Cimone, ma il suo corpo non era più stato trovato, disperso dai bombardamenti. Così assunse la sua identità arruolandosi nell’esercito italiano.
Ho scelto questo approfondimento perché volevo conoscere meglio l’identità dei Bergamas e sapere perché avevano scelto loro per rappresentare e scegliere il Milite Ignoto.
Il Milite Ignoto di Martina B.
È un militare morto in guerra il cui corpo non è stato identificato e che si pensa non potrà mai essere identificato. La sua tomba è una sepoltura simbolica che rappresenta tutti coloro che sono morti in un conflitto e che non sono mai stati identificati. Il Milite Ignoto è un militare italiano caduto durante la prima guerra mondiale e sepolto a Roma, sotto la statua della dea Roma. La salma del Milite Ignoto partì dalla stazione ferroviaria di Aquileia il 29 ottobre del 1921 e arrivò a Roma per essere tumulata all’interno del Vittoriano il 4 novembre, simbolo del sacrificio per amore della Patria.
Un viaggio accolto con entusiasmo e partecipazione.
La salma fu scelta dalla madre di un sottotenente disperso che si chiamava Maria Bergamas, in rappresentanza di tutte le donne italiane, mamme e spose di soldati dispersi nella Grande Guerra.
Le ricerche dei soldati di Desirée B.
Il 24 agosto 1920, il generale Giulio Douhet dichiarò: “Tutto sopportò e vinse il soldato. Perciò al soldato bisogna conferire il sommo onore, quelle cui nessuno dei suoi condottieri può aspirare, neppure nei suoi più folli sogni di ambizione. Nel Pantheon deve trovare la sua degna tomba alla stessa altezza del Re e del Genio”.
Il Decreto sulla sepoltura della salma di un soldato ignoto venne approvato dal Parlamento del Regno d’Italia il 4 agosto 1921 all’unanimità e senza dibattito; come luogo della tumulazione fu scelto il Monumento a Vittorio Emanuele II, noto anche come Vittoriano. Fu stabilito che le ricerche della salma dovessero essere condotte nelle zone più avanzate dei principali campi di battaglia, in totale undici siti: San Michele, Gorizia, Monfalcone, Cadore, Pasubio, Campo Sile, Alto Isonzo, Asiago, Tonale, Monte Grappa, Montello.
Fu Gabriele D’Annunzio a dare il nome di Milite Ignoto alla salma del soldato senza nome che avrebbe celebrato gli eroismi e i sacrifici della Grande Guerra: il soldato che avrebbe rappresentato idealmente tutti coloro che non fecero ritorno a casa, coinvolgendo così tutte le famiglie italiane. Venne così istituito un Ufficio Onoranze al Soldato Ignoto e venne poi nominata una Commissione che dal 3 al 24 ottobre si dedicò alla ricerca di undici salme di soldati provenienti dai campi di battaglia. Quindi le ricerche iniziarono ufficialmente il 3 ottobre 1921.
La Commissione decise di esaminare una salma nei pressi di Rovereto, ma non venne rinvenuta nessuna salma sepolta, e allora se ne esumò una tra quelle di ignoti in un vicino cimitero di guerra.
La ricerca della seconda salma si svolse nei pressi del Massiccio del Pasubio, ma come per la prima non ci furono risultati, e allora si esumò un altro cimitero di guerra. Per trovare la terza salma, la Commissione decise di spostarsi sull’Altopiano di Asiago, sul Monte Ortigara, dove per la prima volta venne trovato un caduto insepolto ma nascosto; probabilmente perché il corpo, non potendo essere seppellito per bene, venne solo nascosto/coperto per evitare che venisse straziato dagli animali.
La quarta salma venne rinvenuta sotto ad una croce e non aveva alcun elemento che favorisse la sua identificazione. Le quattro salme ritrovate fino a quel momento vennero lasciate a Bassano, mentre la Commissione partì per Conegliano e, facendo una sosta sul Montello, cercò la quinta salma che trovarono, però, in un vicino cimitero di guerra. Inoltre, tra le intenzioni della Commissione c’era quella di recuperare la salma di un caduto della Regia Marina, ma l’unica possibilità era quella di riesumare la salma di un marinaio, e cercarono dunque sui campi di battaglia dove i marinai combatterono a terra come fanti. La Commissione si trasferì poi a Cortina d’Ampezzo. Dai racconti emerge che le ricerche furono svolte sulle Tofane e sul Passo Falzaredo, ma non venne trovata alcuna salma, e anche il corpo del settimo soldato venne esumato da un cimitero di guerra. Il 20 ottobre la Commissione si recò sul Monte Rombon, e anche lì venne ritrovata una croce di legno ormai marcita, che aiutò a trovare l’ottava salma. La nona venne invece rinvenuta sul Monte San Michele, vicino alla scavo di una trincea, al disotto di una croce. Furono poi le ricerche a Castegnevizza del Carso, dove venne trovato un palo di legno avvolto con del filo spinato, che fecero pensare ad una trincea, dove venne trovato il decimo corpo. Le ricerche per l’undicesima salma si concentrarono in un tratto di fronte tra Castagnevizza e il mare. Anche là venne ritrovata una croce e così anche l’ultima salma fece il suo ingresso a Gorizia. Nella chiesa di Sant’Ignazio, proprio a Gorizia, vennero celebrati gli undici soldati e tutti i caduti della guerra in una solenne marcia funebre, come eseguita per la prima volta in occasione dei funerali di re Umberto I.
Ritengo che l’omaggio alla Nazione con la scelta simbolica di un soldato anonimo sia un meraviglioso gesto di umanità e solidarietà: è come se il Milite Ignoto possa essere il figlio, il marito, il padre dell’intera Nazione, e per quanto sia triste il fatto che non tutti abbiano potuto seppellire i propri cari, l’idea di averlo fatto simbolicamente può aver alleggerito gli animi, e aver dato un po’ di speranza ad ogni madre, moglie e figlia, che i soldati seppelliti fossero proprio i loro uomini.
Maria Bergamas di Aida S.
Maria Maddalena Bergamas, nata il 23 gennaio 1867 a Gradisca d’Isonzo, negli anni dell’adolescenza si trasferì a Trieste, che ai tempi faceva parte dell’impero austroungarico. Fu così che il suo unico figlio maschio si dovette arruolare nell’esercito austriaco, ma nel 1916 Antonio, così si chiamava, abbandonò l’esercito austriaco per arruolarsi nel 137° Reggimento di Fanteria della Brigata “Barletta”, sotto falso nome imposto dal Regio Esercito. Il 16 giugno 1916, mentre guidava l’attacco del suo plotone, durante un combattimento, fu ucciso da una raffica di mitraglia. Nelle sue tasche fu trovato un biglietto in cui pregava di avvisare il Sindaco della sua morte, siccome era l’unico che era al corrente della sua identità, il suo corpo fu sepolto insieme agli altri caduti nel cimitero di guerra di Marcesina, sull’Altopiano dei Sette Comuni. A seguito di un violento bombardamento che distrusse il cimitero, il suo corpo diventò introvabile.
Maria, dopo la guerra, fu incaricata di scegliere il soldato tra gli undici caduti non identificati scelti per avere la salma del Milite Ignoto da portare al Vittoriano per ricordare tutti i caduti della guerra. Il 28 ottobre 1921, nella Basilica di Aquileia, Maria fu posta davanti alle undici bare allineate. Sulla seconda bara appoggiò il suo grembiule nero, dopo essere passata davanti alle prime. Non riuscì a proseguire: alla destra della bara si accasciò sul feretro urlando il nome del figlio. Per questo motivo fu scelta quella bara per rappresentare i militi senza nome. Maria morì il 22 dicembre 1953 a Trieste. Infatti, dopo qualche anno, andò a vivere nella casa dove abitava e dove una targa ricorda che lì nacque Maria Bergamas.
Ho scelto di fare la ricerca su Maria Bergamas per il gesto che ha fatto. Accettare l’incarico che le è stato affidato, scegliere una delle undici bare e non sapere in quale e se poteva esserci il corpo del figli, è stato un gesto di solidarietà per tutte le mamme che avevano perso il proprio figlio senza avere un corpo su cui piangere: posso solo immaginare il dolore che hanno provato. Se fossi stata al posto di Maria non sarei riuscita a scegliere neanche di accettare l’incarico.
La dignità e gli onori ai soldati caduti in guerra di Davide Z.
La richiesta di dare giusta dignità e gli onori ai soldati caduti in guerra è partita dal popolo e dalle amministrazioni comunali ed ha coinvolto artisti e letterari che sono arrivati all’istituzione nel 1919 di una Commissione che ha onorato la memoria dei soldati d’Italia e dei Paesi alleati, morti in guerra.
Il 1921 era l’anno della scelta del combattente che poi è diventato il rappresentante del sacrificio dei seicentomila italiani persi, decisione lasciata a Maria Bergamas di Trieste che aveva in famiglia un soldato disertore dall’esercito austriaco per arruolarsi nelle file italiane che era morto combattendo senza che il suo corpo fosse identificato.
Davanti ad undici bare chiuse, la donna cadde in ginocchio vicino ad una di esse e avrebbe scelto il Milite Ignoto che era l’eroe simbolo di coraggio, orgoglio, sacrificio e devozione che poi sarebbe stato riconosciuto con tutti gli onori il 4 novembre 1921, ponendolo nel sacello all’Altare della Patria.
Nel primo dopoguerra le istituzioni sono a lungo state impegnate in una lenta e difficile operazione di conta dei caduti in battaglia.
Al ritorno alla normalità si pone il problema della loro collocazione, dal momento che i cimiteri non sono in grado di accogliere tutti i corpi. Ma è possibile individuare già, dai primi anni dalla fine del conflitto, una sorta di prima fase del fenomeno di commemorazione dei caduti in cui sono l’iniziativa e il sentimento popolari a prevalere, con l’appoggio delle amministrazioni comunali.
A livello locale si moltiplicarono le iniziative mirate all’erezione di monumenti in memoria dei caduti in battaglia, e secondo un processo di commemorazione finalizzato a restituire dignità e onore a coloro che si erano battuti a costo della loro stessa vita in una guerra massacrante.
I comuni hanno adottato sin da subito provvedimenti volti al recupero delle somme necessarie, nonostante le difficoltà economiche del periodo.
Il mio parere è che, dopo la guerra, il riconoscimento del monumento al Milite Ignoto è stato molto importante.
